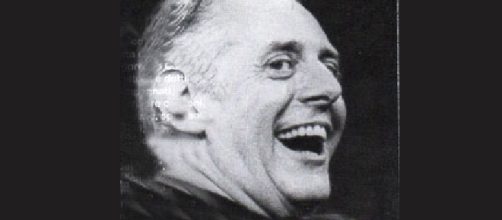Nel 1997, quando l'Accademia di Svezia annunciò che avrebbe assegnato a Dario Fo il Premio Nobel per la Letteratura, il mondo culturale italiano andò in subbuglio. Non era considerato, da critici ed esperti, nella rosa dei possibili vincitori. C'erano in lizza il portoghese José Saramango, Salman Rushdie, Hugo Claus, Jaan Kroos e tra i connazionali il candidato più autorevole era considerato Mario Luzi, per cui da anni i letterati italiani chiedevano l'agognato riconoscimento.
Luzi stesso, dopo l'annuncio del 9 ottobre, si scatenò in modo inaudito e dichiarò alla stampa che il conferimento del Nobel a Fo era «una manifesta malintenzione nei confronti della cultura italiana, una specie di schiaffo» pur ammettendo di non conoscere le opere del rivale, preferendogli Testori o De Filippo.
Altri si unirono alla cantilena: «Dario Fo? Chi è costui?». Eppure non era per niente vero, Fo lo conoscevano bene un po' tutti. Nel mondo già oltre trecento sue commedie erano già state messe in scena e in lizza per il Nobel il suo nome c'era già da vent'anni.
Le commedie di Fo
Ma lo scontro in realtà inizia molto prima. Dopo aver esordito negli anni '50 in radio e televisione prima da solo e poi con la moglie Franca Rame, anch'essa attrice e autrice, Fo viene perseguitato dalla censura e i suoi testi satirici trovano maggiore compiutezza in teatro, dove insieme alla moglie mette su una compagnia e recita commedie esecranti in luoghi dal contesto fortemente popolare come piazze, fabbriche e case del popolo.
Paradossalmente, volendo prendere le distanze dal mondo borghese fatto di lotte intestine, compromessi, favoritismi che coinvolgono in larga misura anche le cose dell'arte e quindi il teatro stesso, Fotrova invece un nuovo modo di fare teatro, e le sue commedie prendono letteralmente vita. E così nasconoMistero buffo, Morte accidentale di un anarchico e quel grammelet beffardo che lo renderà maledettamente diverso e così unico rispettoaltri autori di teatro.
Fo ha ritrovato la sua rivalsa proprio nel suo modo di fare arte e, come ha saputo intuire l'Accademia di Svezia in modo lungimirante, nella sua capacità di dileggiare il potere restituendo dignità agli oppressi. Quindi, che lo critichino, e noi lo continueremo ad applaudire.