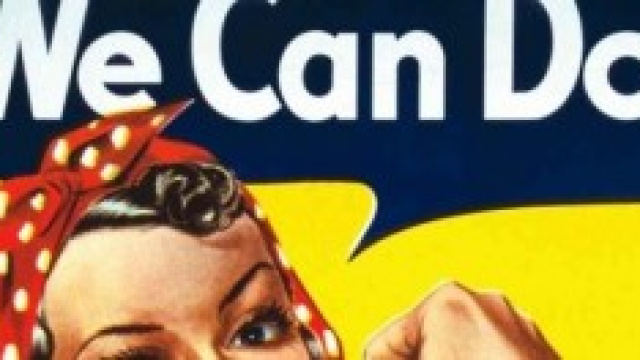Un dato è passato in sordina in queste ultime elezioni europee: sui 5 candidati espressi dai partiti alla guida della Commissione europea, solo uno è donna. Il 20%! Una percentuale che non si registrava ormai da anni. È un segnale negativo? Speriamo di no. Bisogna tener conto anche del fatto che si tratta di elezioni di vertice dove la rappresentanza femminile non ha mai raggiunto percentuali da performance, diciamo così.
Ma realmente vediamo da vicino le parlamentari europee quante sono, in totale. Il 35% dell'assemblea, 261 su 736, dato che migliora quello del 2004 (31%) ma ancora lontanissimo dalla agognata parità di genere.
Ci si può consolare pensando alla recente riforma della legge elettorale, ricordando che giusto trent'anni fa, nel 1979, le donne del primo Parlamento europeo erano praticamente a macchia di leopardo, cioè il 16% degli eletti. Attualmente il Nord la fa ancora da padrone. Sono infatti 8 i Paesi Ue che possono vantare una presenza femminile sopra il 40%, tutti nordici: Finlandia con addirittura il 61%, Svezia (55%), Estonia (50%), Olanda (48%), Danimarca (46%), Francia (46%) e Austria (41%). Invece la lista delle nazioni più "maschiliste" parte proprio dal sud con Malta, solo una donna in Commissione, per salire poi verso il Lussemburgo (16% di elette) e la Repubblica Ceca (18%). Subito dopo, i Paesi a forte tradizione cattolica: Polonia (22%) ed infine il trio Italia, Irlanda e Lituania con il 25%.
Le precedenti elezioni europee, hanno portato una scarsa rappresentanza femminile in Europa, anche se maggiore rispetto alle elezioni ancora precedenti. Il vero "scombussolamento" in Europa è avvenuto nel 2009, con le elezioni europee di poco anteriori all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che hanno visto l'ingresso tra i deputati dell'Unione, i rappresentanti della Bulgaria e della Romania, portando a 736 gli onorevoli e contestualmente fissando, con il Trattato di Lisbona entrato poi in vigore, la soglia massima dei deputati a 751. Si è registrato, così, un rimescolamento delle alleanze che ha portato in superficie l'antico problema della collocazione dei centristi tra i gruppi PPE o PSE, proprio mentre in Italia si sfaldava il bipolarismo, messo in discussione dalla crisi dei partiti FI e PD e l'ingresso sulla scena politica del M5S.
Su questo scenario si colloca il discorso delle politiche al femminile, leit motiv della campagna per le politiche 2012 di Pier Luigi Bersani che può vantare di aver portato il 40% delle donne nel Parlamento italiano.
Eppur si muove! La gioia è che in casa nostra, alle precedenti elezioni, il dato 2004 per intenderci, era del 20%, in linea con le presenze registrate alle amministrative 2008 (21%). Insomma, per le italiane è più facile ottenere un seggio a Bruxelles che a Roma.
E allora resta da fare un'analisi di merito sulle politiche al femminile per poterci convincere una volta di più, se necessario. Perché quel che conta davvero è l'importanza degli spazi da occupare. Diciamo che il risultato dell'analisi resta positivo ma con l'immancabile declinazione superiore al maschile.
Vuol dire che alle ultime elezioni europee, quelle del 2009, è risultato che le presidenti di Commissione, hanno fatto un bel salto in avanti passando dal 25% al 41%: significa che oggi 9 poltrone su 20 sono occupate da donne.
Sempre in attivo, ma tristemente, la situazione per le vicepresidenti (passate dal 25% al 36%, cioè 31 su 87 posti), dove le italiane codirigono con uomini le Commissioni Commercio e Industria. Poi troviamo i 'terzi vicepresidenti', Lara Comi del PPE (mercato interno) e la collega di partito Iva Zanicchi, in missione europea sul fronte dello sviluppo economico.
Le due Commissioni che esercitano il massimo potere, quella degli Affari Esteri e quella del Bilancio, sono espresse da soli uomini.
E altro esempio, la Conferenza dei Presidenti, l'organismo che raccoglie i rappresentanti dei gruppi politici e detta l'agenda dei lavori parlamentari, c'è una sola donna su 11 membri. Anzi, mezza donna, se si guarda al voto, perchè è una co-presidente, il suo voto vale solo una metà. Si tratta di Rebecca Harms, che deve dividere la carica col collega Daniel Cohn-Bendit e insieme valgono un voto dei 9 che l'assise può esprimere.
Quindi a questo punto registriamo un altro dato interessantissimo: le donne in generale non hanno accesso facile ai fondi, siano essi europei o del parlamento di residenza; i loro ministeri, nella maggior parte delle volte, sono senza portafoglio, mentre hanno un facilissimo accesso alle politiche contro la violenza, sia essa di genere o entro le mura domestiche o trasformata in fenomeni come mobbing o stalking. E chissà perchè.